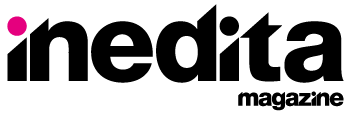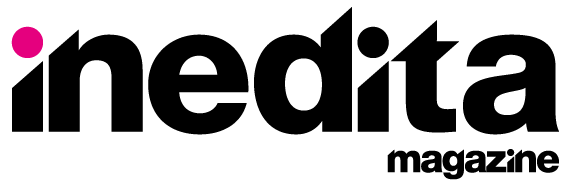Harmattan, Isi, Kamal ed altre storie di ordinaria disperazione
Harmattan ha un occhio tumefatto e lacrimoso. Avrà vent’anni, viene dal Ghana, è accovacciato a terra nell’angolo più buio della cella. Non si è ancora mosso da quando la sera prima lo hanno portato in carcere per spaccio. Harmattan, come il grande e libero vento del Sahara. Isi, albanese, rasato, con una canottiera nera e tatuaggi in ogni dove, si allena con flessioni da superpalestrato, incastrando i piedi alle sbarre della porta imbottite da stracci per evitare lesioni alle caviglie. Carlo, ragazzino biondo e occhiali spessi, è ipnotizzato davanti alla televisione accesa. Segue il processo di Forum, quasi a volersi proteggere, schermare. Kamal, cinquant’anni, forse più, è arrivato dalla Tunisia molti anni fa. Spacciatore e tossico, una vecchia conoscenza delle nostre galere, traffica con la bomboletta del gas per scaldarsi un caffè. Accanto un’altra cella, c’è Ivan, occhi chiari, lucidi, inumiditi, persi. Persi neppure più nei suoi pensieri. Persi solamente, sembrano.
Parla con me lentamente di condizioni inumane, di un improbabile parente che dovrebbe accoglierlo in una cittadina del Sud Italia dove vive, proprio davanti al mare e ottenere così i domiciliari. Parla, parla ma i suoi occhi non mi guardano mai, piuttosto si posano delicati e struggenti su una grande farfalla che porta tatuata sul braccio, quasi a chiederle di prendere il volo, di portarlo lontano da lì, da quell’inferno che ormai lo ha inesorabilmente ospitato.
Le dita abbrustolite dalle sigarette fumate convulsamente, una via l’altra. Probabilmente nessun piacere nel fumo, se il fumo può dar piacere, sicuramente nessun dolore nel mozzicone corto, corto che ormai brucia le dita bruciate. Ivan è giovane, poco più che vent’anni, un corpo enorme e semi-inanimato, una triste mongolfiera dai colori spenti, ormai dal combustibile esaurito. Una mongolfiera, penso io, che difficilmente riuscirà a riprendere il volo. Ivan fuma, parla e addenta un panino prelevato nella sacca-dispensa attaccata alla porta della cella. Ogni cella ha una sacca-dispensa, dentro frutta, qualche altro alimento e pane. Tanto pane. E poi ancora una cella e c’è Vlady, un giovane rumeno, è detenuto in attesa di giudizio per tentato omicidio, piange e grida la sua innocenza.
Con lui Hannes, lui arriva da un villaggio vicino a Essaouira, quello spettacolo di posto che si affaccia su un mare immenso e cristallino. Assai diverso il suo attuale affaccio, cemento e ancora cemento, spesso talmente fatiscente e inumidito da essere divenuto una specie di ospitale e produttiva serra del lichene. Potrei proseguire, ogni cella un racconto, una disperazione.
“Quindici metri quadrati, compreso il cesso fatiscente: tazza, lavandino, carta igienica, spazzolini e aggeggi, tutto sgradevolmente confuso”
Neppure nel punto più emarginato e disgraziato di New York ti imbatteresti in tanto capitale umano. L’immagine dell’interno delle sezioni a Sollicciano sembra in bianco e nero, come i film d’altri tempi. Appena quindici metri quadrati, compreso il cesso fatiscente: tazza, lavandino, carta igienica, spazzolini e aggeggi, tutto sgradevolmente confuso. È un’immagine che si ripete cella dopo cella, sempre uguale.
Cambia solo il tempo, torrido, umido o gelato a secondo delle stagioni e che si intravedono dalle inferriate ricavate nelle apertura del cemento. Visito da tanti anni le carceri della Toscana e non solo. Mi interesso, come posso, delle condizioni dei detenuti, delle questioni strutturali degli istituti penitenziari, delle problematiche sanitarie, ormai all’emergenza. Spesso carceri, inutili, addirittura dannosi, Sollicciano su tutti. Sollicciano da abbattere, per molti.
Qualche dato in Toscana? Quest’anno oltre 30 suicidi, più del 75% sono affetti da patologie, prevalentemente psichiche, poi malattie infettive e parassitarie, del sistema circolatorio, malattie endocrine, del metabolismo e immunitarie, dell’apparato digerente e dell’apparato respiratorio. Dati che sono simili a quelli della situazione nazionale e che hanno portato all’Italia una condanna da parte della Corte di Strasburgo per trattamenti detentivi contrari ai diritti umani. Continui e drammaticamente allarmati i richiami del Presidente Mattarella e di papa Francesco che ha addirittura annunciato di aprire il prossimo anno santo dalla porta di un carcere. Sono convinto che chi commette un reato debba scontare una pena, ma questo non può voler dire negare la sua dignità di persona.
In numerose carceri, invece, si vivono situazioni al limite. Ecco perché penso che il nostro Stato, assai in ritardo, debba porre, non solo a parole, la questione carceraria nell’agenda delle priorità. “Le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato”. è quanto recita l’illuminato articolo 27 della nostra Costituzione.

Riflettiamo bene, non si tratta di giustificare i reati dei detenuti, ma di utilizzare il periodo trascorso in detenzione come occasione che favorisca il recupero sociale del detenuto. Teniamo persone rinchiuse per anni a oziare, ammassandone nella stessa cella, diverse per lingua, cultura, religione in una decina di metri quadri, magari ancora in attesa di giudizio e spesso con la probabilità di dividere la cella con carcerati più “esperti”. Non è difficile pensare che possano uscire ancora più preparati e determinati a compiere altri reati. Data l’altissima
percentuale di recidiva, tra le più alte in Europa, dobbiamo interrogarci sull’efficacia dell’attuale sistema. Anche per questo occorrono misure alternative: comunità, lavoro, studio, mestieri. Ad esempio continuo a chiedermi: a cosa serve tenere i tossicodipendenti nelle
carceri? Un detenuto affidato alla comunità costa circa un terzo di quanto paghi l’amministrazione carceraria. E i risultati sono documentati. Insomma, l’interesse alla sicurezza da un lato e il recupero sociale dei detenuti dall’altro non possono appartenere più a contrapposte ideologie. Certo, si tratta di percorsi complessi che richiederebbero un maggiore sostegno alla prevenzione anziché alla repressione
o all’aumento della sanzione. Ma è questo il campo della sfida. E le nostre Regioni, che hanno la responsabilità sanitaria degli Istituti, non possono permettere che i continui, talvolta necessari tagli di risorse, ricadano sempre e comunque anche sulle carceri.
“Tanto lì non si pesca sul consenso”. Il tutto, certo, non va scisso dalla netta condanna per i reati, dalla vicinanza alle vittime, spesso anch’esse deboli, indifese. Vittime di vittime. Dico solo che non possiamo pensare di aver risolto il problema rinchiudendo il colpevole “che marcisca in galera!”.Tutt’altro, pena il rischio della moltiplicazione del problema. Non possiamo più sottrarci.
Dobbiamo curare quell’occhio ad Harmattan, rieducarlo, farlo lavorare ed insegnargli un mestiere. Far sì che il vento torni a soffiare nella legalità.

Spesso artisti, personaggi dello spettacolo mi hanno accompagnato nelle visite e si sono offerti di raccontare e regalare qualcosa della loro arte. L’ultimo giorno dell’anno di qualche tempo fa mi accompagnarono Lorenzo Cherubini Jovanotti e Riccardo Onori.
Fu una mattinata intensa, uno spiraglio di umanità. Lorenzo introdusse il piccolo concerto con queste parole: “Che ci si possa sempre rialzare proprio fino all’ultimo attimo. C’è anche una mia canzone che chiude dicendo che fino all’ultimo attimo, fino all’ultimo attimo.
Fino all’ultimo attimo ci si può sempre rialzare, mettere un lieto fine alla propria storia. Perché poi, quello che mi sembra, camminando oggi in questo posto, è che ognuno ha una sua storia. Tante cose abbiamo in comune anche se le nostre vite sembrano così diverse.
Spesso sono più le cose che abbiamo in comune di quelle cose che ci dividono. Poi ognuno di noi ha la sua storia, fatta di bellezza, fatta a volte di tragedia, di errori, di errori che si pagano.
Ma ognuna di queste storie può sempre rimettersi in piedi. Anzi, può sempre imparare dagli errori fatti, a volte addirittura anche ripeterli… perché quante volte si ripete lo stesso cammino! Ma la possibilità di rialzarsi e di rimettersi in piedi credo che sia la cosa per la quale ho iniziato a credere nella musica. La musica mi ha raccontato questo, spesso la musica racconta questo…
Oggi vorrei cantarvi un paio di canzoni, se vi va. Canzoni che parlano della vita, che poi alla fine è l’unica cosa della quale vale la pena parlare. La vita senza giudizio, senza morale.
Ognuno ha la sua e se la gioca con la propria coscienza e cerca di andare avanti migliorandosi, perché questa è l’unica cosa che veramente so: ci si può migliorare, si può crescere. Si può diventare un’altra persona mantenendo un cuore coraggioso e mantenendosi sempre vivi.
La prima canzone è Fango, il fango è quella cosà lì…”